.
Me ne stavo l’inverno a studiare, in lunghi pomeriggi, sotto lo sguardo della nonna ad ascoltare i suoi intermittenti racconti del marito morto e della di lui famiglia di giocatori d’azzardo e di gran puttanieri.
Immaginavo lì sul tavolo da gioco, in qualche villa vetusta del solito barone decaduto, forse nella sbrecciata foresteria, o addirittura in cucina, con la cuccuma del caffè instancabile sopra i dischi concentrici della stufa, con le serve assonnate a portata di mano da palpare, sotto il cono di luce di pochi watts per risparmiare, immaginavo dicevo una serie di spostamenti non di cambiali e pagherò ma di miniature di case con terreno annesso che si affacciavano sul basso Adriatico anch’esso miniaturizzato, con il colore blu e qualche triglia guizzante, così come li coloravo nelle mie ricerche di geografia per il maestro Rosa.
Un fantasma di croupier spostava con la sua palettina pezzi di collina coltivata a vigna, appartamenti nella città del retroterra, lembi di spiaggia con rovina, spuntoni di rocche immemori abbarbicate su grigi calanchi instabili, tutto in piccola scala e realizzati da bravi maquettisti iperrealisti.
I calessi parcheggiati sull’aia che sfiorava la spiaggia, sotto tamerici e pini sghembi, erano anch’essi messi in gioco sul tavolaccio di rovere ove si animavano architetture e paesaggi monchi, mitologie proprietarie diluite da fiumi di sperma, di figli illeggittimi, di serve infilzate da abortivi lunghi sporchi ferri da calza.
Immaginavo donne sveglie al mattino che si ritrovavano senza più casa e terreno, nemmeno quell’orticello conquistato con la schiena piegata sino a ottant’anni, quel quadricciattolo di basilico e pomodori, zucchine e finocchio che se te lo tolgono muori e poi dicono che sei morta nel sonno tranquilla e invece per tutta la notte ti rivoltavi perché ti avevano espropriato la vita stessa.
Uomini che andavano avanti con fiaschi di vino e ozio, chiavate alle serve e alle loro figlie allampanate e ammaestrate a seghe e pompini, con mogli sorelle nonne bisnonne zie prozie nipoti figlie a tirarti fuori dal letame in cui cadi sbronzo e ripulito dal gioco.


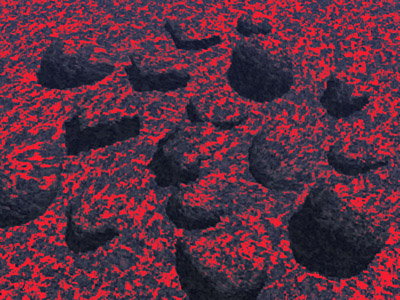



 .
.

